Agostino sarebbe il vero prosecutore dell’empito paolino. Il Vescovo d’Ippona ha sempre cura di considerare l’ira divina nel suo significato di castigo – dal momento che Dio è impassibile, immune dalle emozioni, come dice Salomone: “Tu però, Signore delle Potenze, giudichi con tranquillità”. Già nel Contra Adimanto aveva insistito – in polemica coi Manichei – che passioni quali l’ira e la misericordia, quando riferiti a Dio, non si dovevano intendere letteralmente. Dio, per Agostino, non può essere collerico: come più tardi per Tommaso, Dio è “iratus non irasceris”, “irato ma non si adira”, intendendo l’ira come la manifestazione del dolore e dello sdegno di Dio nei confronti dei peccatori. La cui massima espressione sarà nel giorno dell’ira, in quel Dies Irae in cui Dio chiamerà a giudizio tutti e si dorrà dei peccati dei molti.
Quel giorno, Dio chiuderà la Storia: quel che è al di là del giudizio sarà distinto e separato da quello che è ancora al di qua, non soltanto relativamente, ma assolutamente […]. E il mutamento che deve essere preso in considerazione dove Dio parla ed è conosciuto come giudice, è così radicale, che esso appunto unisce in modo infrangibile tempo ed eternità, giustizia umana e giustizia divina, al di qua ed al di là”[1]. Il Dies Irae è dunque il vero ultimo solco, il discrimine, il vallo tra il tempo e l’eternità. Sotto il segno dell’ira accade “la più radicale liquidazione della storia, il “No” sotto il quale cade ogni carne, la crisi assoluta che Dio significa per il mondo degli uomini, del tempo e delle cose”. Infine, alla fine dei tempi, “la sottomissione all’ira di Dio è la fede nella sua giustizia”[2].
Con l’avvento del Cristianesimo ed il suo imporsi, sorge un nuovo interrogativo che s’innesta sull’antico: se la nuova religione si propone come centrata sull’amore, sul perdono, sulla rinuncia alla vendetta (“offri l’altra guancia”), come può mantenersi ancorata ad un’escatologia così furiosa? Già le Lettere di Paolo, e poi Tertulliano nel corso del II secolo, Lattanzio un centinaio d’anni più tardi, Sant’Ambrogio e San Tommaso e gli altri Padri della Chiesa avevano cercato di rendere compatibile il thymós di Dio con le sue altre, nuove caratteristiche. Spiegando perché anche il Dio cristiano non solo sia potenzialmente capace d’ira, ma debba essere adirato nell’attualità. Per i teologi, insomma, non si può omettere l’ira dallo spettro delle caratteristiche di Dio, pur se le passioni in quanto tali non possono incontrarsi che nell’uomo. 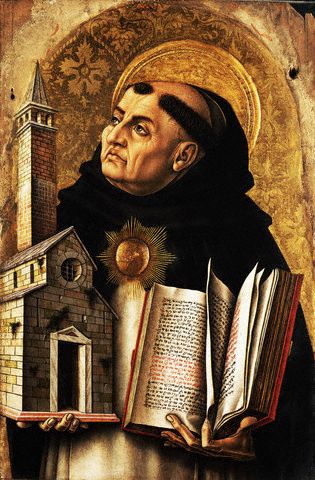 Scrive Tommaso: “Deus autem non potest ab alio tristitiam pati, quantumvis peccatis offendatur; Ergo cum punti peccata, non irascitur proprie; sed effectu ipso ita se gerit, ac si esset iratus”[3]. Come già per Ambrogio, il giudizio divino non è contaminato da passioni ed influssi di sangue, e neppure dalla tristezza per dover infliggere la pena.
Scrive Tommaso: “Deus autem non potest ab alio tristitiam pati, quantumvis peccatis offendatur; Ergo cum punti peccata, non irascitur proprie; sed effectu ipso ita se gerit, ac si esset iratus”[3]. Come già per Ambrogio, il giudizio divino non è contaminato da passioni ed influssi di sangue, e neppure dalla tristezza per dover infliggere la pena.
Nella Somma teologica, Tommaso è netto al riguardo: “Alcune tra le virtù morali hanno per oggetto le passioni; così la temperanza ha per oggetto la concupiscenza; la fortezza il timore e l’audacia, la mansuetudine l’ira. E tali virtù non si possono attribuire a Dio altro che per metafora, perché in Dio non vi sono né passioni, come si è detto sopra, né vi è l’appetito sensitivo, nel quale risiedono tali virtù come dice il Filosofo. Vi sono invece altre virtù morali come la giustizia, la liberalità e la magnificenza: che hanno per oggetto le operazioni, e cioè le donazioni, le spese e simili: ed esse non risiedono nella parte sensitiva, ma nella volontà. Quindi niente impedisce che tali virtù si attribuiscano a Dio, non certo per delle azioni di carattere sociale, ma per azioni confacenti a Dio. Sarebbe, infatti, ridicolo, come osserva il Filosofo, lodare Dio per le sue virtù politiche”[4].
Tuttavia, Dio fa il viso dell’arme, e spesso; lo scoppiare fragoroso della sua ira, giacché questa non è nella sua natura, è dovuto allora all’aver riscontrato nell’uomo una risposta imperfetta, mancante, peccatrice.
Andiamo un attimo alla Lettera ai Romani, il testo paolino forse più esplicito ed insieme problematico riguardo al nostro tema. Scrive Paolo: “Ma se la nostra insubordinazione dimostra la giustizia di Dio, che cosa dobbiamo dire di ciò? Dio stesso non è allora ingiusto nel dar corso alla sua ira? (Io parlo secondo la logica umana!) Impossibile! Poiché, come si spiega allora che Dio giudica il mondo?”[5].
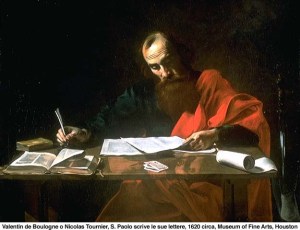
Paolo scrive le lettere, Valentin de Boulogne, 1621
Solo nell’inadeguatezza dei suoi eletti Dio si dimostra veramente Dio – aveva spiegato poco prima Paolo. In altri termini, solo se l’uomo pecca Dio può dimostrare la sua giustizia. Ma se l’insubordinazione dell’uomo serve a dimostrare – diciamo così – la giustizia di Dio, che diventa questa giustizia, si chiede Karl Barth con Paolo nel commento alla Lettera?: “Non è essa stessa ‘insubordinazione’? Dio stesso non è forse arbitrariamente sovrano, non è forse un io superiore degno di essere addirittura temuto per il suo carattere criminale? La sua ira, la nostra dedizione alla signoria del non-Dio (1: 22-32) non testimonia allora contro di lui? Lo stato del mondo e dell’uomo non è forse allora la vera espressione della più intima essenza di Dio, che è una insondabile, capricciosa tirannia? Se il non-senso della storia dimostra il suo significato nascosto, questo significato stesso non è allora necessariamente un non-senso?”[6].
Barth risponde, con Paolo, che occorre parlare del vero Dio, del Giudice del mondo che non è però parte del mondo. Le nostre domande/obiezioni sono altrimenti viziose, non colgono un punto decisivo: il vero Dio non è ‘insubordinato’, non è ‘arbitrario’, non è ‘capriccioso’. Perché? “Perché soltanto nel suo giudizio, contrapponendosi a Lui, l’insubordinazione, l’arbitrio, il capriccio che regnano nel nostro mondo si manifestano alla nostra coscienza nella loro problematicità”.
Per il fedele, resta una difficoltà aggiuntiva. Risulta davvero difficile capire come si possa credere ed amare un Dio che – essendo onnisciente – già si adira al pensiero che una delle sue creature ancora non create un giorno peccherà, mandandogli così di rispetto. Commenta Sloterdijk non senza ironia: “Chi si chiede ancora come l’ira possa essere suscitata contro il peccatore insensibile prima che il peccatore destinato a peccare faccia il suo ingresso nell’esistenza, dovrebbe prendere in considerazione l’ipotesi che egli stesso non sia un contenitore destinato alla frantumazione [riprendendo l’immagine paolina di Lettera ai Romani, IX]”[7].
Tradizionalmente, l’ira di Dio “dipende” dall’onnipotenza, dalla giustizia o dall’amore del Creatore. Un primo problema insorge proprio dalla dicotomia onnipotenza-giustizia: lo nota già Paolo, e se ne ritrae quasi terrorizzato, opponendo alla logica (perché la libera onnipotenza di Dio è responsabile, diciamo così, artefice forse è meglio, di molti più fatti nel mondo rispetto a quelli che possono esser soddisfatti con il principio di giustizia?) un assioma: che l’uomo non può chiedersi perché, di fronte all’operato di Dio.
Sarà possibile allora dedurre l’ira dalla giustizia? Anche questo è un terreno minato. Intanto, perché come ammonisce Tommaso d’Aquino, è complicato predicare di Dio la giustizia, perché in effetti la giustizia sembra doversi predicare degli atti, non delle essenze. Tommaso trova questa risposta: “Sebbene la giustizia riguardi l’operazione, non per questo, tuttavia, si esclude che si identifichi con l’essenza di Dio, perché anche ciò che appartiene all’essenza di una cosa può essere principio di azione. Ma il bene non riguarda soltanto l’atto, perché una cosa si dice che è buona non solo in quanto agisce, ma anche in quanto nella sua essenza è perfetta. E per questo motivo nel luogo citato si dice che il concetto di bene sta al concetto di giusto, come il genere alla specie”[8].
Se non si usano gli occhi della fede, difficile accontentarsi. Secondo Sloterdijk, “l’ira, fatta passare come conseguenza della giustizia, ubbidisce in verità ad una logica di maestà politica. Questa s’incarna in un teatro immaginario della crudeltà che fa durare in eterno ciò che nel tempo non sarebbe sopportabile per un secondo”[9]. Oltretutto, si tralascia un’incongruenza teologicamente non irrilevante, come la derivazione di una colpa infinita da una colpa finita. Perché la giustizia di Dio infligge tormenti eterni a chi è stato attore di colpe pro tempore? Ma, direbbe Paolo, piantiamola col farci queste domande, di per sé incongrue, dal momento che è assurdo che un uomo voglia darsi conto del volere dell’Altissimo.
Resta la derivazione dell’ira di Dio dal suo amore. Da Lattanzio in poi, chi ha sostenuto questa origine stressa la bipolarità – per dire così – della vita affettiva di Dio: se non odiasse gli infedeli e gli ingiusti, Dio non potrebbe amare i timorati ed i giusti. Perciò, Dio è iroso a ragione.
I teologi cristiani post-medioevali cercarono una via per sfuggire agli eccessi teologici dell’ira. Per i peccati veniali, possibile finire all’Inferno? E fu così che inventarono il terzo luogo, il Purgatorio, nuovo modello e matrice della Storia, nel corso della quale l’umanità si costituisce come collettivo globale capace di liberarsi, passo dopo passo, dal peso dei suoi peccati minori. Da questo punto di vista, la reazione di Lutero al fenomeno delle indulgenze fu davvero reazionario, nostalgico della logica dell’entweder/oder, dell’alternativa binaria Inferno/Paradiso, secondo la quale nulla era possibile al fedele. Viceversa, la Chiesa cattolica aveva imboccato un innovativo sistema di credito: “in esso si potevano diminuire con dei pagamenti anticipati i quanti d’ira divina negoziabili per peccati veniali – un procedimento che ricorda, non solo superficialmente, il moderno acquisto a rate”[10]. Mi avvicino la salvezza, scontando oggi – con spesa modica o ingente, dipende dalle colpe – parte di quel che dovrò espiare tra le mezzeluci del Terzo regno, in Purgatorio.
[1] Karl Barth (1954), L’Epistola ai Romani, edizione italiana a cura di Giovanni Miegge, pag. 51.
[2] Ivi, pag. 52.
[3] Tommaso d’Aquino, Dispos., 84, cap. VI, vol. I, 341°.
[4] Tommaso d’Aquino, Somma teologica, I (Dio), questione 21
[5] Paolo Apostolo, Lettera ai Romani, V. 5-8.
[6] Karl Barth (1954), L’Epistola ai Romani, cit., pag. 56.
[7] PS, IeT, cit., pag. 121.
[8] Tommaso d’Aquino, Somma teologica, I, 21, art. 1.
[9] PS, IeT, cit., pag. 123.
[10] Ivi, pag. 130.
