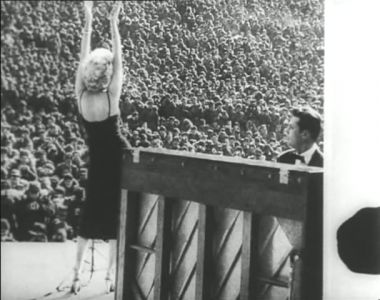E io ch’avea d’error la testa cinta,
dissi: «Maestro, che è quel ch’i’ odo?
e che gent’ è che par nel duol sì vinta?».
Ed elli a me: «Questo misero modo
tegnon l’anime triste di coloro
che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo.
Mischiate sono a quel cattivo coro
de li angeli che non furon ribelli
né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro.
Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno, canto III
Mi sono sempre chiesto perché Dante mise gli ignavi, quelli che non prendono posizione, nell’Inferno. Anzi nemmeno in quello! Il poeta s’inventò l’Antinferno per queste anime tristi, che se fossero scese nell’Ade avrebbero fatto sì che i dannati si sarebbero potuti glorificare rispetto ad essi; avendo loro almeno scelto, nella vita, da che parte stare, sia pure nel male. Io mi sentivo però una di quelle povere anime, non riuscivo a vedere l’assoluto bene da una parte e l’assoluto male dall’altra. Perché dovevo essere condannato in modo peggiore di chi aveva scelto il male? Finalmente ho avuto una piccola rivincita attraverso Sloterdjik e Lakoff che, rispettivamente, con il proclama del pensiero polivalente e del biconcettualismo, mi hanno salvato dal correre nudo per l’eternità dietro un vessillo, per di più tormentato da vespe e mosconi.
Queste salvifiche concezioni forse avrebbero anche potuto evitare a Julian la terribile morte che si procurò dandosi in pasto ai maiali. Mi sto riferendo allo spettacolo teatrale Porcile, di Pasolini, nell’edizione tenutasi al teatro Argentina nello scorso dicembre. Julian non prende posizione, come dice il padre “non è né obbediente né disobbediente“, non sta con i capitalisti e nemmeno con chi protesta. Un ignavo con tutti i crismi insomma. L’ignavia però secondo me, in accordo con Sloterdjik, significa innanzitutto l’impossibilità di essere fondamentalisti.
Alla base del fondamentalismo delle tre grandi religioni monoteiste vi è il pensiero monovalente, basato su un linguaggio che non ammette negazioni, che deriva però dalla possibilità, data dalla logica classica bivalente, che esse vi siano: un’asserzione può essere vera o falsa, tertium non datur.
Secondo il filosofo tedesco “Il pensiero diventa rigido non appena insiste sul fatto che, tra due istanze, solo una può essere quella giusta per noi… Il fanatismo ha la sua origine logica nel non contare oltre il numero uno, il quale non sopporta niente e nessuno accanto a sé. Questo Uno è la madre dell’intolleranza: secundum non datur.”[1] Ora, non voglio dire che Dante fosse un fondamentalista, si è detto che rispettava comunque chi si schierava dalla parte del male (anche se poi lo condannava alle pene eterne), ma il suo era il pensiero bivalente che aveva permesso la nascita del fanatismo. Tuttavia, l’invenzione del Purgatorio[2] – quel terzo luogo dinamico che permetteva di mantenere il controllo sui credenti rispettandone le accresciute esigenze terrene – mostra che tale pensiero già conteneva in nuce, la possibilità del passaggio a quello che per Sloterdjik è il farmaco contro gli estremismi: il pensiero polivalente.
Mentre la logica bivalente non dà altre alternative oltre al sì e al no, “il pensiero quotidiano ha trovato da sempre delle vie verso il tertium datur. Il procedimento universalmente adottato in questo ambito consiste nel togliere radicalità alle alternative: si metta qualcuno dinanzi a un aut aut che gli risulti sgradito e si vedrà come prima o poi questi si trasformerà il compito in un “sia-sia”… Un grigio che è liberazione dal peso di dover scegliere tra bianco e nero“[3].
Ecco il primo farmaco che poteva salvare Julian: il pensiero quotidiano, non logico! Ciò che gli avrebbe permesso di passare dal né-né al sia-sia. Una sorta di ignavia positiva, che, secondo Lakoff, è peculiare del cervello umano. Con ignavia innanzitutto non si stiamo parlando di una visione del mondo moderata, o la ricerca della medietà in tutte le cose (tra l’altro Sloterdjik dà un duro giudizio sulla medietà, in Ira e Tempo, cap.4, la chiama “mostro informe”). Per Lakoff non esiste un “centro”, il nostro cervello ha la capacità di tenere insieme i poli contraddittori e usarli a seconda del contesto. Questa capacità è ciò che lui chiama biconcettualismo: “Biconceptualism makes sense from the perspective of the brain and the mechanism of neural computation. The progressive and conservative worldviews are mutually exclusive. But in a human brain, both can exist side by side…“[4]. Le rigide opposizioni sono tali solo per il pensiero fondamentalista, monoconcettuale, compreso quello illuminista. D’altronde già Hegel si scagliò contro quella razionalità, per lui propria dell’intelletto, che non riesce a tenere insieme gli estremi; la ragione hegeliana è invece quella che riesce a comprendere e a concettualizzare tutte le istanze umane. Si può dire, in termini moderni, una ragione multiconcettuale.
Ecco, senza questo tipo di ragione il secondo farmaco, che già Spinoza aveva teorizzato, cioè tenere insieme ragione e passioni non può funzionare. Non è sufficiente dire si alla vita se questa non acquista senso, o meglio se non c’è una ragione aperta a tutti i significati possibili. Spinoza nel porcile però tiene conto della ragione di quel tempo, illuminista, ed esorta Julian ad abbandonarla, a seguire il suo impulso, le sue passioni, perché usare solo quella ragione avrebbe sempre favorito il più forte, il tecnocrate: “…una volta che, spiegato Dio, la Ragione ha esaurito il suo compito, deve negarsi: non deve restare che Dio, nient’altro che Dio“[5] . Ma negare la ragione e spostarsi solo sul sentimento porta al rifiuto totale, all’azione del santo, sacrificale. Un’azione forse inizialmente necessaria, che dovrà costringere a cercare un’alternativa al mondo dato. In effetti Julian si poteva salvare con due farmaci che potevano essere prodotti solo dopo un’azione di rottura come la sua, condotta dalla sua ignavia; questi sono appunto la ragione multiconcettuale, attraverso la quale “imparare a guardarsi sempre con gli occhi degli altri con una serie di discipline vincolanti dal punto di vista interculturale: la cultura universale“[6], e il dar voce alle passioni, cioè valorizzarle come motore della nostra Storia.
[1] Peter Sloterdjik, Il furore di Dio, Raffaello Cortina Editore Milano 2008, pagg. 94-95
[2] Se già i padri della chiesa si erano preoccupati circa un terzo luogo di espiazione dei peccati minori, fu solo nel XII secolo che un teologo parigino, tal Pietro Cantore, inserì nei suoi studi il purgatorio.
[3] Id., pagg. 111-112
[4] Lakoff G., Thinking points: Communicating Our American Values and Vision, cap.2, Paperback 2006
[5] Pasolini P.P., Porcile, in Pasolini Teatro, Mondadori, Milano 2001, pag. 636
[6] Sloterdjik P., Ira e tempo, Meltemi, 2008, ultima pagina