La ragione di stampo illuminista – quella a torto privilegiata dai democratici e dai progressisti, secondo Lakoff e Westen – avrebbe le seguenti caratteristiche. Sarebbe:
- – consapevole – sappiamo quel che pensiamo;
- – universale – la stessa per tutti;
- – disincarnata – libera dal corpo ed indipendente da percezione ed azione;
- – logica – consistente con le proprietà della logica classica;
- – non emotiva – libera dalle passioni;
- – assiologicamente neutrale – la stessa ragione si applica indipendentemente dai valori;
- – basata sull’interesse – al servizio dei proponimenti e degli interessi individuali;
- – letterale – in grado di rendere precisamente un mondo obiettivo, una logica della mente in grado di rendere la logica del mondo.

George Lakoff
Ma davvero funzioniamo così, si chiede Lakoff? Prendiamo il caso di chi vota contro i propri interessi, una vasta fetta dell’elettorato, in America come in Europa, in particolare in Italia – stando alle analisi sociologiche del dopo-voto che hanno spesso messo in mostra che una percentuale significativa del voto operaio è andata a partiti di destra, espressione tradizionale del ceto confindustriale: bene, secondo Lakoff costoro consentono che quelli che oggettivamente possono essere considerati errori [bias], pregiudizi ed emozioni guidino le loro decisioni.
E ciò si deve al fatto che – come Damasio ha dimostrato (ma prima di lui Spinoza, direi) – la ragione invece richiama l’emozione, ne è il correlato. Come Bodei va dicendo da vent’anni, dovremmo avere a cuore una ragione appassionata e avere confidenza con passioni ragionevoli – non domesticate, appannate, depotenziate. Sullo sfondo, appare ancora irrinunciabile e gonfio di sviluppi il pensiero di Freud, soprattutto quello della seconda topica. E assai feconda di spunti filosofici decisivi la riflessione di Ignacio Matte-Blanco e della sua bi-logica, secondo la quale anche l’inconscio ha una sua logica, diversa ovviamente da quella della mente razionale.
Prima di procedere nell’esposizione delle posizioni di Lakoff, un inciso. Si affaccia qui subito infatti un problema classico: quello del determinismo. Se ammettiamo che le nostre funzioni cerebrali sono tutt’uno con quelle mentali e se il nostro pensare non è disincarnato, come vorrebbe la logica pura di stampo illuminista, allora non ci sarebbe mai possibile cambiare le nostre visioni del mondo morali e politiche a piacimento. Nel senso che modelli di pensiero politico e morale sarebbero determinati dal come funzioniamo coi nostri corpi sia nel mondo fisico che in quello sociale. Cambiare mentalità comporterebbe anche cambiare i nostri cervelli, quasi direi anatomicamente parlando. Un cambiamento di mentalità corrisponderebbe, sinapsi più sinapsi meno, ad un cambiamento neurologico-psichico: questa, grosso modo, la volgarizzazione possibile, ma direi quasi necessaria, che esita dall’impostazione di cui ci stiamo occupando.
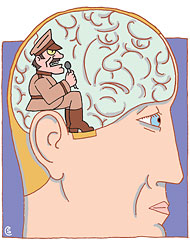 In effetti, la politica – per quanto possa inquietare questa affermazione – ha molto a che fare col cambiare i cervelli, e con essi la mentalità della gente. Ricorderete i discorsi sessantottini sulla manipolazione delle coscienze? Beh, è peggio: qui – adottando l’ottica di Lakoff – si tratta di mettere mano agli organi che determinano le funzioni, prima che a queste ultime. Consapevoli che in campo avverso fanno lo stesso da tempo e con ottimi risultati – come già aveva compreso Pier Paolo Pasolini, quando denunciava il genocidio culturale dell’Italia perbene – in senso forte.
In effetti, la politica – per quanto possa inquietare questa affermazione – ha molto a che fare col cambiare i cervelli, e con essi la mentalità della gente. Ricorderete i discorsi sessantottini sulla manipolazione delle coscienze? Beh, è peggio: qui – adottando l’ottica di Lakoff – si tratta di mettere mano agli organi che determinano le funzioni, prima che a queste ultime. Consapevoli che in campo avverso fanno lo stesso da tempo e con ottimi risultati – come già aveva compreso Pier Paolo Pasolini, quando denunciava il genocidio culturale dell’Italia perbene – in senso forte.
Se invece ci acquietiamo in una visione settecentesca della mente, allora crederemo che sarà sufficiente mostrare alla gente fatti e cifre affinché prendano la “giusta” decisione. Saremo certi che tutto ciò che è necessario è far vedere in che consistono i loro interessi: la gente allora agirà in modo da massimizzarli da un punto di vista politico. Saremo certi che chiedendo alle persone quali sono i loro interessi, esse ne saranno consapevoli, li enumereranno e voteranno in conformità. Non ci servirà appellarci alle emozioni. Inutile in fondo anche parlare di valori: fatti e cifre saranno sufficienti e parleranno da soli. Inutile anche cercare di cambiare la testa della gente: la loro ragione sarà sufficiente. Chi non ci vota ancora, lo fa per ignoranza, o per corruzione o malafede.
Vi sembra che il ragionamento fili? Eppure, non pochi partiti e movimenti progressisti ragionano ancora proprio in questi termini. E infatti vincono gli altri che non credono – dice Lakoff – in questo meccanismo deterministico.
Queste riflessioni si rispecchiano anche in una serie di domande tipiche che il campo progressista si sente rivolgere da tempo, anche dal proprio interno: perché i Democratici sono così “saputi” ? Cosa li divide al loro interno?
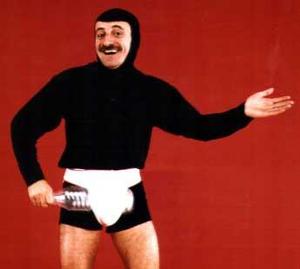 Perché il “tafazzismo” è di sinistra? Perché i conservatori sono così più bravi nel diffondere le loro idee? Perché i Democratici statunitensi non sono stati capaci di fare di più, una volta preso il controllo del Congresso, nel 2006 e hanno lasciato che George W. Bush governasse ancora due anni? E più in generale, perché esistono conservatori poveri che votano a destra contro il proprio interesse? Perché non ha mai funzionato un populismo democratico? Perché i candidati democratici presentano una lista di programmi dettagliati, mentre i Repubblicani no?
Perché il “tafazzismo” è di sinistra? Perché i conservatori sono così più bravi nel diffondere le loro idee? Perché i Democratici statunitensi non sono stati capaci di fare di più, una volta preso il controllo del Congresso, nel 2006 e hanno lasciato che George W. Bush governasse ancora due anni? E più in generale, perché esistono conservatori poveri che votano a destra contro il proprio interesse? Perché non ha mai funzionato un populismo democratico? Perché i candidati democratici presentano una lista di programmi dettagliati, mentre i Repubblicani no?
La risposta è semplice: perché i progressisti tendono a non far propria una mentalità profonda che tenga conto, e si giovi, di una mente in larga misura inconscia, incarnata, empatica, metaforica e solo parzialmente universale. Come ha dimostrato Charles Fillmore, ogni parola è definita relativamente almeno ad un contesto [frame] concettuale. Quel che la semantica cognitivista avrebbe scoperto, e che Lakoff propugna, è che noi pensiamo in termini di sistemi di concetti, sistemi che si adattano, s’incastrano e che compongono senso. Esisterebbe innanzitutto un sistema di metafore primarie, acquisite durante l’infanzia; questo processo avviene grazie al modo in cui l’apprendimento neurale funziona. Per esempio, se tutti i giorni uno versa dell’acqua in un bicchiere e vede il livello salire, ogni singolo giorno il cervello registrerà che quantità e verticalità coesistono: entrambe sono registrate contemporaneamente dal cervello; i due processi sono entrambi attivati allo stesso tempo, ma in zone diverse del cervello. A causa della propagazione dell’attivazione delle loro connessioni a varie parti del cervello e a molti pathway – e attraverso questi – l’attivazione si propaga attraverso le vie metaboliche fino a quando vengono a congiungersi da entrambe le estremità formando circuiti neurali; questi circuiti che si formano sono le metafore. E le persone ne imparano tantissime, semplicemente vivendo nel mondo, semplicemente osservando quali tipi di cose accadono contemporaneamente. Per cui si divertono e si stupiscono quando vedono quel trucco per cui, versando del liquido in un bicchiere, il livello del liquido stesso non sale. Perché, appunto, si aspettano il contrario.
Un Nuovo Illuminismo, a detta di Lakoff, non significherebbe fare a meno della ragione, ma piuttosto capire che nella realtà di tutti i giorni facciamo uso di una ragione reale, una ragione incarnata, configurata dai nostri corpi e dai nostri cervelli e dalle interazioni con la realtà; una ragione che incorpora l’emozione, strutturata in contesti e metafore, immagini e simboli, con il pensiero conscio configurato dal vasto ed invisibile ambito dei circuiti neuronali inaccessibili alla consapevolezza. Cambiare opinione, dunque, implicherebbe un reframing, un risettaggio dei nostri schemi inetrpretativi della realtà. 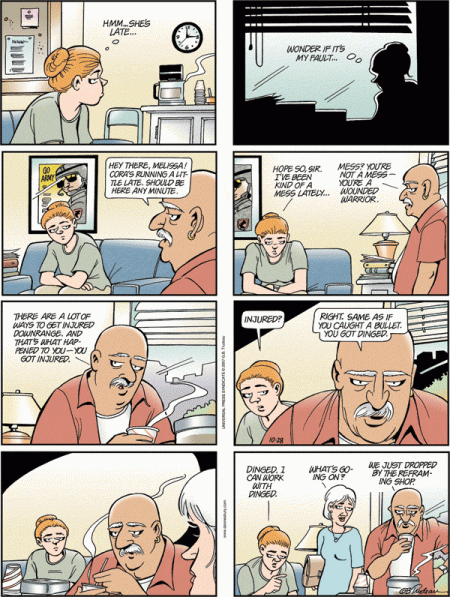
Un Nuovo Illuminismo non farebbe a meno nemmeno delle narrazioni culturali, rimpiazzandole con la fredda, dura ragione. Le narrazioni culturali fanno parte dell’arredamento permanente dei nostri cervelli: sono metafore complesse dell’esistenza, strutture che ci aiutano ad orizzontarci ed a vivere meno difficilmente. Sono i miti, le favole, i proverbi, i luoghi comuni di cui è intessuta la nostra esperienza quotidiana. Tutto ciò non sarebbe destinato a sparire, ma almeno saremmo consapevoli e riconosceremo che tutti ci viviamo le nostre narrazioni. Sarebbe quindi normale interrogarsi su di esse, ponendo la questione di quanto influenzino la nostra vita e se possiamo metterle o meno da parte.
 In questi giorni in
In questi giorni in 
 Negli ultimi trent’anni è stato scoperto molto riguardo al rapporto tra la mente e il cervello, e ciò avrebbe dovuto ormai – a detta di Lakoff – aver confinato tra parentesi le teorie illuministe al riguardo – e per quel che mi riguarda, anche le teorie riduzioniste, biologizzanti. Secondo Lakoff, invece, la maggior parte della gente non ha idea dei passi avanti che si sono fatti e men che meno gli apparati dei partiti politici (specie in campo progressista) che il più delle volte non valutano con la dovuta attenzione le nuove acquisizioni delle scienze cognitive. Questo comporta diverse conseguenze politiche. L’idea che muove The Political Mind è proprio di favorire una conoscenza della mente che metta in evidenza le sue conseguenze politiche, a vantaggio – lo si dice esplicitamente – del campo progressista, da trent’anni in affanno negli Stati Uniti, almeno prima della clamorosa affermazione di
Negli ultimi trent’anni è stato scoperto molto riguardo al rapporto tra la mente e il cervello, e ciò avrebbe dovuto ormai – a detta di Lakoff – aver confinato tra parentesi le teorie illuministe al riguardo – e per quel che mi riguarda, anche le teorie riduzioniste, biologizzanti. Secondo Lakoff, invece, la maggior parte della gente non ha idea dei passi avanti che si sono fatti e men che meno gli apparati dei partiti politici (specie in campo progressista) che il più delle volte non valutano con la dovuta attenzione le nuove acquisizioni delle scienze cognitive. Questo comporta diverse conseguenze politiche. L’idea che muove The Political Mind è proprio di favorire una conoscenza della mente che metta in evidenza le sue conseguenze politiche, a vantaggio – lo si dice esplicitamente – del campo progressista, da trent’anni in affanno negli Stati Uniti, almeno prima della clamorosa affermazione di  Il compito forse più importante della scienza cognitiva consisterebbe proprio nello svelare quali tipi di idee derivano da dove, quali sono le loro implicazioni, etc. È per questo che la mancata comprensione della scienza cognitiva da parte dei leader politici, dei loro staff, dei commentatori e dei giornalisti politici ha creato in America – a detta di Lakoff – una situazione disastrosa, almeno dal punto di vista Democratico. I commentatori politici, i giornalisti e gli studiosi hanno per anni usato le metafore e i frame “di destra” come se fossero neutrali, e – senza neanche accorgersene – hanno finito per favorire la linea politica avversaria.
Il compito forse più importante della scienza cognitiva consisterebbe proprio nello svelare quali tipi di idee derivano da dove, quali sono le loro implicazioni, etc. È per questo che la mancata comprensione della scienza cognitiva da parte dei leader politici, dei loro staff, dei commentatori e dei giornalisti politici ha creato in America – a detta di Lakoff – una situazione disastrosa, almeno dal punto di vista Democratico. I commentatori politici, i giornalisti e gli studiosi hanno per anni usato le metafore e i frame “di destra” come se fossero neutrali, e – senza neanche accorgersene – hanno finito per favorire la linea politica avversaria.
