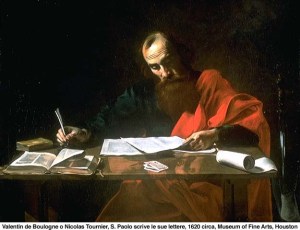I sentimenti timotici sono forti e rilevanti, ma nell’ambito delle riflessioni e delle analisi novecentesche sulla galassia sentimentale sembra sia stata riservata loro scarsa considerazione; l’attenzione si sarebbe concentrata di più sulla disposizione erotica dell’individuo, sui suoi rapporti verso gli altri e con il mondo. La mia ipotesi è che nel costituirsi della felicità individuale rientrino invece anche fattori timotici, e che il loro essere sottostimati dalla nostra cultura abbia un ruolo ai fini della sua generalizzata assenza, nella diffusa infelicità personale.
In altre parole, per esser felici sembra necessario un Sé fondato non soltanto sulle capacità erotiche del soggetto (i sentimenti-verso, come vien detto; la capacità di amare innanzitutto, e poi quella di provare compassione e pietà per gli altri, l’empatia, così rilevante per un settore degli studi cognitivisti d’oggi, ed infine il desiderio di possesso), ma è necessario probabilmente che la personalità individuale appagata poggi anche su di un sentimento di sé fatto di autostima, di orgoglio personale, di desiderio legittimo di esser riconosciuti dagli altri. Appunto, su quei sentimenti timotici oggi tendenzialmente silenziati nella cultura “progressista” o democratica che tende ad assimilarli tout court al narcisismo.
Dagli anni Settanta in poi, volendo indicare una data, ci si è gradualmente distaccati dall’antico primato della timotica, ancora attuale al tempo degli empiti rivoluzionari e socialisti, a vantaggio di un’erotizzazione senza confini, di una ri-privatizzazione delle illusioni. Se il passato timotico aveva visto il predominio assiologico dei valori combattenti, oggi – nella sfera avanzata del consumo – amare, desiderare e godere conchiudono l’orizzonte e diventano il primo dovere. Cadono i precetti di astinenza e – per esprimersi con Sloterdijk – s’impongono nuovi comandamenti morali fondati sul desiderio ed il godere pubblicamente e sulla responsabilizzazione dell’individuo nella competizione per il godimento.
Ma nonostante il primato dell’erotico, i sentimenti timotici permangono. Ed a volte si esasperano, se non si riesce ad essere felici attraverso l’erotizzazione del proprio orizzonte di attesa. Vivendo in una banlieu di Marsiglia od in una bidonville di Lagos o di Messico, al centro di un universo multicentrico che ha smarrito la periferia, surclassato dalle proposte del lusso e dell’erotica, come si può sfogare la frustrazione per non avere ciò che i media dicono ci spetti? Il latore d’ira contemporaneo non ha scenari che lo orientino, non ha porte Scee o mura sotto le quali far scempio di nemici – anzi, a ben vedere, non sa neppure chi sono i suoi nemici. E non ha neppure narrazioni convincenti che gli assegnino un posto conveniente negli avvenimenti mondiali di cui, comunque, è chiamato a far parte, da ogni angolo: dalla televisione, dalla cartellonistica, da Internet, se vi ha accesso.
Ed è allora che il drive timotico viene surrogato perseguendo illusoriamente la felicità attraverso il ritorno alle invenzioni etniche e sub culturali della storia. E se queste non sono disponibili, subentrano al loro posto delle costruzioni locali noi-loro. Dallo spaesamento, la fuga in se stessi. E per trovarvi conforto, l’espulsione dalla propria immagine del sé di ogni aspetto perturbante. Lo straniero, il diverso, il barbaro non è che il fantasma della singolarità diversa da sé che non riusciamo ad accettare senza provare paura.
 Sradicamento e felicità
Sradicamento e felicità
Non serve pensare queste soggettività irrelate per forza a Mumbay o a Manila. E’ sufficiente abitare in val Chiavenna, o in un qualunque paesino di quella città infinita che va da Milano a Treviso. Ovunque, la dissoluzione dell’identità sociale è caratterizzata dall’instaurarsi di relazioni “più corte”, circoscritte ad un orizzonte spazio-temporale di più facile controllo. Si ricorre al già noto, alle differenze si sostituiscono criteri di uniformità spacciati per differenze.
Si fa di tutto, pur di sentirsi meno infelici, meno precari, meno dispersi, meno assediati dall’altro e dal diverso. Ci si riesce meglio se non si è soli; una ricerca inglese condotta di recente su quasi cinquemila soggetti seguiti per 20 anni attesta che la felicità è un fenomeno collettivo, come la salute. Nel senso che la felicità individuale è fortemente correlata alla felicità degli altri che ci attorniano[1].
I protagonisti atomistici di questa communitas che tale non è, una cosa importante la condividono eccome: ed è la dinamica del desiderio nei confronti delle cose, innescata da quelle che Bonomi chiama “le piccole fredde passioni” tipiche dell’attuale fase storica e che appartengono in pieno alla declinazione erotica del soggetto. Insomma, ci si deve accontentare dei beni di qua, se quelli di là non ci vengono più presentati con la stessa incisività e persuasione di una volta dalla maggiore e, in apparenza, affidabile banchiere della storia, la Chiesa, amministratore delegato dell’eternità per conto di Dio.
Oggi la fede cristiana è in crisi (non così quella musulmana, invero, almeno dal punto di vista numerico), mentre quella nel capitalismo – nonostante le profonde ferite inferte all’ambiente e le turbolenze finanziarie dei mercati – gode di una salute migliore e la felicità viene sempre più ricercata attraverso il possesso di beni materiali. Come dimostra la fenomenologia della ricchezza del Nord Italia illustrata appunto da Aldo Bonomi, vi è un vasto mercato di merci concepite proprio per soddisfare i desideri erotico-edonistici delle persone.
Ma che ne è del mercato dei desideri timotici? C’è la stessa offerta? Dopo il fallimento delle due banche universali dell’ira alle quali Sloterdijk si riferisce usualmente – il Paradiso dei Santi e quello dei Rivoluzionari – il mercato delle passioni timotiche ha subito una contrazione avvilente che ha fatto sì che, in capo ad una ventina di anni, l’offerta di Befriedigung dei desideri timotici – di soddisfazione nel senso hegeliano di appagamento, base e fondamento di ogni possibile felicità terrena, reale e non illusoria – sia stata quasi monopolizzata dalle organizzazioni politiche della Destra.
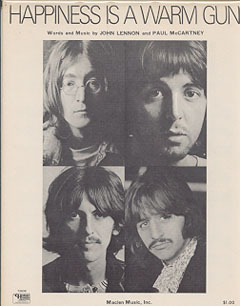 La sottovalutazione dell’universo timotico, in politica, è propria principalmente dei progressisti democratici, che hanno probabilmente scontato più della controparte quella fiducia eccessiva – “illuministica” – nell’evidenza della ragione, prendendo le distanze sia dalle passioni timotiche “al positivo” (onore, amor proprio, orgoglio, stima, ecc.), sia da quelle troppo facilmente connotabili “al negativo” – come l’ira, la paura, la rabbia, il rancore, eccetera.
La sottovalutazione dell’universo timotico, in politica, è propria principalmente dei progressisti democratici, che hanno probabilmente scontato più della controparte quella fiducia eccessiva – “illuministica” – nell’evidenza della ragione, prendendo le distanze sia dalle passioni timotiche “al positivo” (onore, amor proprio, orgoglio, stima, ecc.), sia da quelle troppo facilmente connotabili “al negativo” – come l’ira, la paura, la rabbia, il rancore, eccetera.
Per essere disponibili alla felicità, sosteneva Marx, è meglio essere atei ed essere attivi, avere un lavoro. Se non ci si illude su di un domani ultraterreno, si dovrebbe essere più disponibili ad apprezzare il mondo ed a cercarvi una felicità non demandabile ad un futuro escatologico. Il lavoro – se non alienato, per dirla con Marx – porta a socializzare e quindi ad incontrare – con maggiori probabilità rispetto ad una pratica di vita solipsistica – una felicità che sembrerebbe essere un fenomeno collettivo, oltre che individuale. Il lavoro inoltre è un potente collettore timotico, in grado di rafforzare l’orgoglio, l’amor proprio, l’autostima.
Sarebbe quindi il caso innanzitutto che le forze politiche democratiche tornassero a valorizzare il lavoro e le attività nelle quali ci si produce, a difenderle e promuoverle. E che inoltre non tralasciassero quelle passioni non erotiche che pure contribuiscono alla costituzione del sé e ad un processo d’identificazione in grado di soddisfare la persona senza raggelarla nel narcisismo e nella pulsione di morte. Non voglio certo riproporre una versione ammodernata del Bushidō giapponese, del codice d’onore samurai. Ma dove sta scritto che onore, orgoglio, coraggio, autostima debbano restare vuote parole d’ordine strillate dalle curve degli stadi e nei cortei della destra ultrà?
[1] Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study, BMJ 2008;337:a2338.
 Ma il ritorno al passato, al certo, al conchiuso, non comporta affatto un rinsaldarsi della saggezza locale, del genius loci. Anzi: tra gli
Ma il ritorno al passato, al certo, al conchiuso, non comporta affatto un rinsaldarsi della saggezza locale, del genius loci. Anzi: tra gli 

 Oggi la Lega, nonostante i suoi consistenti risultati elettorali, appare in trincea. Non esprime più la novità dei distretti produttivi del Nord, non rappresenta più la politica gregaria dello sviluppo autoregolato dalla società civile, come negli anni Novanta. Il localismo non appare più sufficiente a sostenere la sfida della globalizzazione, la necessità di dar vita ad euroregioni a cavallo delle frontiere. Inutile illudersi di rispondere localisticamente allo spiazzamento generato dall’irrompere della globalizzazione sul territorio ed al contemporaneo affievolirsi dello Stato-nazione. Occorrerebbe piuttosto elaborare quelle strategie di accettazione della sfida globale che Bonomi definisce “
Oggi la Lega, nonostante i suoi consistenti risultati elettorali, appare in trincea. Non esprime più la novità dei distretti produttivi del Nord, non rappresenta più la politica gregaria dello sviluppo autoregolato dalla società civile, come negli anni Novanta. Il localismo non appare più sufficiente a sostenere la sfida della globalizzazione, la necessità di dar vita ad euroregioni a cavallo delle frontiere. Inutile illudersi di rispondere localisticamente allo spiazzamento generato dall’irrompere della globalizzazione sul territorio ed al contemporaneo affievolirsi dello Stato-nazione. Occorrerebbe piuttosto elaborare quelle strategie di accettazione della sfida globale che Bonomi definisce “
 I connotati e le spiegazioni della
I connotati e le spiegazioni della  La forza di Berlusconi, il suo messaggio, si basa sul potere del chiunque che dà identità al molteplice.
La forza di Berlusconi, il suo messaggio, si basa sul potere del chiunque che dà identità al molteplice. La celebrazione del passato (di un passato, scelto ad arte) ci dice che non siamo il prodotto del caso, ma di una storia, quella che ci siamo scelti.
La celebrazione del passato (di un passato, scelto ad arte) ci dice che non siamo il prodotto del caso, ma di una storia, quella che ci siamo scelti.
 Qui mettono al lavoro la loro “nuda vita” le cubiste, i DJ, i PR e i tanti nuovi “attivi senz’opera” nel ciclo del “tempo libero” fatto di parchi-gioco e villaggi-vacanze.
Qui mettono al lavoro la loro “nuda vita” le cubiste, i DJ, i PR e i tanti nuovi “attivi senz’opera” nel ciclo del “tempo libero” fatto di parchi-gioco e villaggi-vacanze.


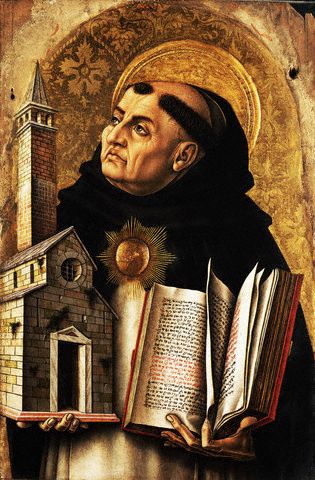 Scrive
Scrive